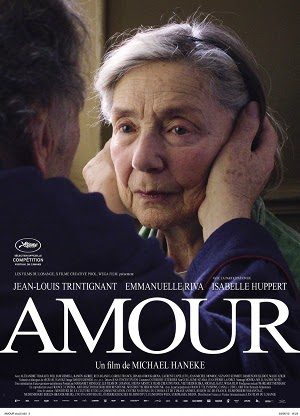Paterson è il dodicesimo lungometraggio diretto nel 2016 dal noto cineasta indipendente Jim Jarmusch.
Il film offre allo spettatore la rappresentazione di una settimana nella vita di Paterson (Adam Driver), un conducente di pullman che si diletta a scrivere poesie e vive in New Jersey, assieme alla moglie Laura e al cane Marvin.
Come è noto a chi conosce il suo stile, Jarmusch privilegia la rappresentazione di individui ai margini della società, alienati da una routine perennemente uguale a se stessa. In questo, Paterson si rivela esemplare.
Il lungometraggio mette in scena una quotidianità monotona, volutamente piatta, e la regia stessa sottolinea gli aspetti che rendono le giornate uguali tra loro. Da questo punto di vista, il film rifugge esplicitamente i concetti cardine della sceneggiatura: in Paterson non ci sono antagonisti, non c’è un obiettivo definito; c’è solo un protagonista che vive la sua normalità.
È lecito affermare, in effetti, che per quasi tutto il film, ad eccezione del finale, non succeda nulla che scuota la narrazione.
Agli occhi dello spettatore, l’unica nota stonata che turba l’equilibrio di Paterson è la moglie Laura (Golshifteh Farahani). Con lo scorrere dei minuti del film, la figura femminile appare lievemente enigmatica agli occhi di chi guarda.
Il personaggio sembra scritto appositamente per risultare fastidioso: pare non apprezzare gli sforzi del marito, che invece la idolatra, e tende a dimostrarsi superficiale se non addirittura lievemente egoista. La stessa resa visiva sembra corroborare questa sensazione: gli onnipresenti motivi in bianco e nero che accompagnano Laura, i suoi vestiti e gli ambienti in cui si muove, se ad una prima occhiata paiono curiosi non tardano però a risultare ridondanti, quasi stucchevoli.
Essa troverà comunque modo di redimersi sul finale del film, a seguito del trauma che scuote il quotidiano del protagonista. La donna, di fronte all’inconveniente, apparirà tutto d’un colpo fragile, tenera e premurosa, permettendo allo spettatore di trovare una giustificazione alla visione che il marito ha di lei.
La critica ha elogiato il film, arrivando a definirlo “un mite e sorprendente lavoro anti-drammatico per i fan del cinema indipendente” (Todd McCarthy, The Hollywood Reporter).
Il progetto è stato a lungo presente nei meandri della mente di Jarmusch, regista e sceneggiatore, che definì le prime bozze della trama addirittura vent’anni fa. Per realizzarlo al meglio, ha deciso di affiancarsi al suo poeta contemporaneo preferito, Ron Padgett.
Quest’ultimo ha composto tutte le liriche che nel film sono attribuite al protagonista. Lo stesso Jarmusch ha però voluto dare il suo apporto alla componente poetica, scrivendo i versi che nel film risultano pensati da una precocissima bambina che Paterson incontra per caso.
In Paterson, il regista gioca anche con la tendenza cinematografica per cui ad un elemento narrativo vengono conferite sfumature di significato simboliche. Esemplare in questo senso risulta il leitmotiv dei gemelli: da quando Laura dice di aver sognato di partorirli, il marito inizia a vederne ovunque.
Questo elemento narrativo è stato inserito direttamente in fase di riprese, quando il regista ha notato che gli attori più piccoli venivano sostituiti, come spesso accade, da fratelli identici. A detta dello stesso Jarmusch, tuttavia, questo topos è privo di significato ulteriore (“anti-significant”).
Lo spettatore potrebbe interrogarsi su eventuali implicazioni narrative (un parto di Laura, altri eventi degni di nota), senza rendersi conto che si tratta di un elemento volutamente privo di significato, che rende il film nella sua totalità ancor più straniante.
Dopo le sue collaborazioni con Baumbach, Spielberg, e i fratelli Coen, l’ormai affermato Driver sin dagli albori della produzione non ha nascosto l’entusiasmo che provava nel lavorare con un caposaldo del cinema contemporaneo quale è Jim Jarmusch.
I più ironici credono che la scelta del protagonista fosse scritta nel destino, data la curiosa coincidenza tra il cognome dell’attore (Driver, in inglese autista) e la natura del ruolo, un conducente di bus. Ma pare addirittura che, per rendersi il candidato più idoneo al ruolo del protagonista, Driver abbia autonomamente deciso di prendere la patente per la guida di autobus, prima che gli fosse richiesto esplicitamente.
In questo modo, l’attore sperava di automatizzare l’aspetto pratico del suo ruolo per potersi concentrare sull’interpretazione al momento delle riprese. Non meno importante, Driver aveva giustamente immaginato che riuscire a guidare realmente gli ingombranti mezzi avrebbe consentito al regista la possibilità di ricorrere a più inquadrature, potendo lavorare con più libertà.
L’acclamato attore interpreta magistralmente il ruolo che gli è affidato. Il suo personaggio risulta a tratti annoiato, teneramente ingenuo.
La componente di fragile semplicità che Driver riesce a incanalare in Paterson lo rende incredibilmente realistico, quasi commovente nella sua purezza. Ciò che colpisce del protagonista è il suo modo di fare, sempre pacato e riflessivo, mai esuberante o eccessivo. Anche nel momento di peggior crisi, di maggior sconforto, non si lascia accecare dall’ira o da manifestazioni plateali di disperazione.
Silenzioso, Paterson cade in un pacato sconforto, comunque carico di intensità e malessere. Tutto ciò che riesce a dire a proposito delle sue poesie, forse perdute per sempre, è un elegante ma disilluso «they where only words written on water», forse citando il celebre epitaffio del poeta inglese John Keats (“Here lies One whose Name was writ in Water”).
La performance di Driver, particolarmente apprezzata, gli ha permesso negli anni successivi di collaborare con altri mostri sacri del cinema contemporaneo tra cui Scorsese (Silence, 2016), Soderbergh (La truffa dei Logan, 2017) e Lee (BlaKkKansman, 2018), fino ad arrivare alla nomination all’Oscar per miglior attore (non protagonista nel 2019 per il film di Spike Lee e protagonista nel 2020 per Storia di un matrimonio di Baumbach).
La narrazione di Paterson si sviluppa dunque attorno a un quotidiano semplice e ciclico, ad una circolarità monotona.
Per questa ragione, un evento perturbatore come quello del finale, che normalmente non sarebbe abbastanza forte da stravolgere l’andamento della storia, assume in questo caso connotazioni drammatiche e riverberi disastrosi.
Gli ultimi minuti del film, però, aprono ad un messaggio di speranza, illustrando come talvolta sia necessario fare un passo indietro per trovare nuove fonti di ispirazione. In questa chiusura molti critici hanno visto una forte dichiarazione da parte dello stesso Jarmusch, che dopo anni di esperienza continua a sorprendere il suo pubblico innovandosi ma rimanendo fedele alla sua concezione artistica.
In effetti, solo una mente creativa così solida ma al contempo propositiva poteva offrire al pubblico un’opera come Paterson, che sfidando qualsiasi convenzione narrativa riesce comunque a colpire dritto nell’animo dello spettatore.


/s3.amazonaws.com/wapopartners.com/wweek-wp/wp-content/uploads/2016/11/14171909/Bump_HarryPotterNickCavefan_WarnerBrosPictures_4303.jpg)